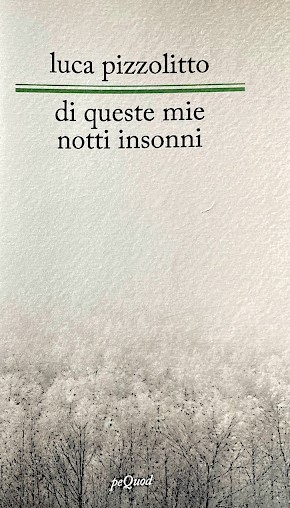Lo “sguardo straniero” del poeta: Questa notte non posso aprire gli occhi di Leda Erente
Come guarda un poeta? La domanda, solo apparentemente oziosa, si ripropone dagli albori delle comunità umane e va al cuore di una questione cruciale. Anche quando il poeta chiude gli occhi per affidarsi a una visione “altra”, per esempio impastata di sogno e di speranza nell’avvenire, giunge a un grado di comprensione che tocca il fondamento misterioso della realtà. Questa notte non posso aprire gli occhi di Leda Erente è quasi un manifesto della “cecità” profetica della poesia che vede ben al di là del visibile. Tiresia o Omero, il poeta qui «richiama gli uccelli a disperdere i suoi versi» (p. 28), ovvero innalza un canto di lode e d’amore a emulazione dei volatili: «mi farò ciotola per raccogliere il tuo verso / e risuonare nel vento» (p. 20). Anche con gli occhi non aperti il poeta «ha la vista del gheppio», come scrive Erente in uno dei testi più belli del libro: «Il tuo amore mette radici. / Ha la vista del gheppio che porta ad afferrare le cime / a contemplare una stella coperta di neve» (p. 37). Come un mendicante affamato di senso e verità, Leda Erente compone dunque un Cantico randagio che bussa con insistenza alle porte del cielo («tutta la notte ho bussato», p. 46) per far coincidere la più radicale delle domande con l’afflato da cui scaturisce la poesia: «Dove sei amore?» (p. 40). Se è vero che lo sguardo del poeta è «straniero» poiché «diverge dal mondo» (p. 55), la scrittura di Erente procede per interrogativi che sono, in ultimo, la cifra di uno stupore bambino, vala a dire di chi si accosta con semplicità a una realtà che non è mai un possesso personale («non del tutto nostro il respiro / non del tutto nostro il battito del cuore», p. 29), bensì un dono per cui ringraziare aprendo «la porta al canto / alla sorgente di luce» (p. 96). E laddove Erente non riesce ad aprire gli occhi, è qualcun altro a farlo per lei. Essere guardati, infatti, è la speranza che infonde ali e canto alla poesia: «Senza il tuo sguardo non possiamo essere interi. / […] / La mia bocca è colma di gioia // Mi lascio cadere» (p. 89). Con questa fede Leda Erente, poeta, guarda il mondo.
(Pietro Russo)
Leda Erente, Questa notte non posso aprire gli occhi, Prefazione di Massimiliano Bardotti, Firenze Libri, Firenze, 2025, collana “Fuori stagione”.